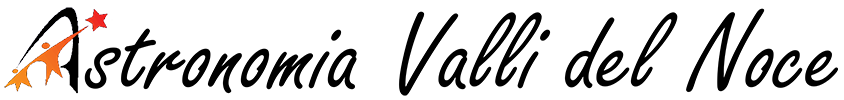Tre pezzetti di cielo. Sono i tre campi profondi resi pubblici oggi dalla missione Euclid. Uno si trova nell’emisfero nord, verso la costellazione del Dragone, non lontano dalle più famose Orsa maggiore e Orsa minore. Gli altri due si trovano nell’emisfero sud. In totale, corrispondono allo 0,1 per cento dell’intera volta celeste, e allo 0,45 per cento della porzione di cielo che il telescopio Euclid dell’Agenzia spaziale europea (Esa) scansionerà nel corso dei prossimi anni. Eppure in questi tre pezzetti di cielo sono già stati identificati 26 milioni di galassie. Un assaggio fugace – ma già parecchio appetitoso – della gigantesca mappa del cosmo in corso di realizzazione per studiare l’evoluzione dell’universo nel tempo e la natura delle sue componenti più misteriose, come l’invisibile materia oscura e l’elusiva energia oscura.
Tre pezzetti di cielo. Sono i tre campi profondi resi pubblici oggi dalla missione Euclid. Uno si trova nell’emisfero nord, verso la costellazione del Dragone, non lontano dalle più famose Orsa maggiore e Orsa minore. Gli altri due si trovano nell’emisfero sud. In totale, corrispondono allo 0,1 per cento dell’intera volta celeste, e allo 0,45 per cento della porzione di cielo che il telescopio Euclid dell’Agenzia spaziale europea (Esa) scansionerà nel corso dei prossimi anni. Eppure in questi tre pezzetti di cielo sono già stati identificati 26 milioni di galassie. Un assaggio fugace – ma già parecchio appetitoso – della gigantesca mappa del cosmo in corso di realizzazione per studiare l’evoluzione dell’universo nel tempo e la natura delle sue componenti più misteriose, come l’invisibile materia oscura e l’elusiva energia oscura.
Trasformare le osservazioni del telescopio spaziale in cataloghi utilizzabili dalla comunità scientifica per testare ipotesi cosmologiche è tutt’altro che banale. Una volta catturate dal telescopio, le immagini grezze vengono sottoposte a un rigoroso trattamento da parte del segmento di terra scientifico (in inglese: science ground segment, Sgs), che coordina l’elaborazione e analisi dei dati, spianando la strada ad analisi e scoperte scientifiche più avanzate. «Il segmento di terra a guida italiana, composto da più di 800 fra scienziati, ingegneri ed esperti di software da diversi paesi, ha sviluppato diverse pipeline necessarie a estrarre le informazioni scientifiche dalle immagini acquisite», nota Andrea Zacchei dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), manager del segmento di terra di Euclid. «Sono stati necessari più di dieci anni per ideare, implementare e finalmente eseguire su dati reali una prima versione di questi complessi software. Da solo questa piccola percentuale di cielo, il segmento di terra ha creato un catalogo composto da 26 milioni di galassie e 4 milioni di oggetti come quasar, stelle, nane brune, e altro ancora. Siamo solo all’inizio; stiamo già preparando la prossima release, prevista fra poco più di un anno, che comprenderà un’area di cielo molto più vasta e analizzata con algoritmi sempre più sofisticati».
La release odierna, chiamata Quick Data Release 1, è sette volte più grande del primissimo set di dati rilasciato da Euclid, le Early Release Observations, che erano state rese pubbliche nel 2024. I tre campi profondi rappresentano le più grandi aree contigue di cielo mai osservate con un telescopio spaziale nell’ottico e nel vicino infrarosso. Se non sembrano spettacolari come le immagini in technicolor sfornate ormai quasi giornalmente dai telescopi spaziali Hubble e Webb, è assolutamente voluto: Euclid è stato progettato non per esaminare singoli oggetti astronomici in tutte le loro minuzie, ma per confezionare l’atlante più grande e più preciso dell’universo su grande scala. Una specie di Google Maps del cosmo, per capirci. L’obiettivo è studiare un vasto, vastissimo numero di galassie: in dettaglio, sì, ma anche e soprattutto nel loro contesto più ampio.
Per questo, il “detective dell’universo oscuro” – come lo chiamano in quel dell’Esa – può fare affidamento sia su un grande campo visivo che sull’alta risoluzione delle immagini. Con i nuovi dati, è possibile condurre molteplici studi astrofisici su scale più piccole, dagli ammassi di galassie fino a oggetti delle dimensioni di un pianeta. Infatti oggi, insieme ai dati e ai preprint di sette articoli tecnici che descrivono il processo di elaborazione e analisi dei dati, vengono presentati anche i preprint di 27 articoli scientifici, dedicati ad argomenti disparati di astrofisica. In gergo, si chiama legacy science: ricerche che si interrogano sulla morfologia, il tasso di formazione, l’evoluzione delle galassie nel corso di miliardi di anni – tutte complementari all’obiettivo scientifico primario della missione, ovvero comprendere il ruolo cosmico della materia oscura e dell’energia oscura.
Il Deep Field North
Ne è un esempio l’immagine dello Euclid Deep Field North, un fazzoletto di cielo grande 22,9 gradi quadrati – l’equivalente di un centinaio di lune piene. A un primo sguardo, si presenta come una manciata di sale e pepe. Ma tra quei “granelli” cosmici si nascondono oltre dieci milioni di galassie. E non solo: l’immagine pullula di stelle, dalla caratteristica forma ad asterisco con una serie di picchi a raggiera (forma che non è intrinseca delle stelle ma causata dall’interazione della luce con le ottiche dei telescopi). Sono stelle della nostra galassia, la Via Lattea, nella quale viviamo e che fa capolino in tutte le nostre osservazioni, anche quelle del cosmo profondo. Si nota anche una leggera nebulosità di colore blu, causata dal materiale diffuso che pervade gli spazi interstellari. E spicca pure una macchiolina di colore fucsia, visibile nella porzione centrale dell’immagine, verso destra.
Andando a ingrandire, la macchia fucsia tradisce la silhouette inconfondibile della Nebulosa Occhio di Gatto (Cat’s Eye Nebula, anche nota come Ngc 6543), una nebulosa planetaria, quel che resta di una stella come il Sole alla fine del suo ciclo vitale, a circa tremila anni luce da noi. Vent’anni fa, il telescopio spaziale Hubble ne aveva fatto un’icona dell’astronomia pop. Senza raggiungere lo stesso grado di dettaglio di altri osservatori, la survey realizzata da Euclid ha il merito di ritrarre oggetti come questo all’interno del più vasto contesto cosmico in cui si trovano.
«Queste immagini mostrano la capacità unica di Euclid di osservare il cielo, combinando un ottimo livello di dettaglio e profondità delle immagini con l’ampiezza della regione osservata», commenta Gianluca Polenta dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), responsabile dell’analisi delle immagini di uno dei due strumenti di bordo, il Near-Infrared Spectrometer and Photometer (Nisp), alla guida di uno degli articoli presentati oggi, sull’elaborazione dei dati nel vicino infrarosso. «Durante i sei anni di osservazioni, Euclid collezionerà centinaia di migliaia di immagini nel visibile e nel vicino infrarosso, la cui analisi è resa possibile da una serie di pipeline sviluppate appositamente dalla collaborazione Euclid con il contributo determinante degli scienziati italiani».
Sempre nello Euclid Deep Field North, aguzzando la vista poco più in alto rispetto al centro dell’immagine, si trova anche la galassia Ngc 6505, a circa 590 milioni di anni luce da noi. Ne abbiamo parlato giusto un mese fa: è la prima lente gravitazionale forte scoperta da Euclid. A causa di una coincidenza cosmica, questa galassia risulta allineata proprio lungo la nostra linea di vista con un’altra galassia, molto più lontana, di cui amplifica e distorce la luce, facendola apparire sotto forma di un cerchio: il cosiddetto “anello di Einstein”. Secondo la teoria della relatività generale di Albert Einstein, infatti, corpi massicci come galassie e ammassi di galassie possono agire come lenti gravitazionali, curvando il tessuto dello spazio tempo circostante e “piegando” così il percorso della luce proveniente da sorgenti retrostanti, le cui immagini vengono amplificate e – nei casi più eclatanti – moltiplicate. Di potenziali lenti forti, nei tre campi profondi, Euclid ne ha già identificate centinaia, grazie alla combinazione dell’intelligenza artificiale e dell’ispezione da parte di un migliaio di citizen scientist attraverso il progetto Space Warps, seguite dalla verifica e modellazione da parte degli esperti.
«Questo mosaico presenta una selezione delle lenti gravitazionali più spettacolari trovate da Euclid nell’area di cielo coperta dalla data release Q1: in totale, sono state identificate oltre 500 lenti gravitazionali su scala galattica e più di 80 ammassi di galassie che producono effetti di lensing gravitazionale forte», sottolinea Pietro Bergamini, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, che ha guidato l’articolo sulla ricerca di lenti gravitazionali. «Nonostante i dati esaminati rappresentino appena lo 0,5% dell’area totale che Euclid osserverà nel corso della sua missione, il numero di lenti gravitazionali individuate è comparabile a quello delle lenti già note fino ad oggi. I dati raccolti da Euclid permetteranno di determinare come la materia oscura si distribuisce all’interno di galassie ed ammassi di galassie, contribuendo in maniera rilevante ad una migliore comprensione della natura della materia oscura stessa».
Il Deep Field South
Il più grande dei tre campi profondi è lo Euclid Deep Field South, una regione del cielo grande 28,1 gradi quadrati in direzione della costellazione dell’Orologio, nell’emisfero sud. Osservando l’immagine, si può intravedere la struttura su larga scala dell’universo, con le galassie disposte lungo la ragnatela cosmica, una gigantesca “rete” composta da ammassi di galassie collegati tra loro da filamenti. Questo campo, in cui Euclid ha già scovato ben undici milioni di galassie, non è stato ancora coperto da nessuna indagine del cielo profondo e offre dunque un grande potenziale per nuove scoperte: sono già stati identificati e caratterizzati diversi ammassi di galassie, molti dei quali presentano grandiosi fenomeni di lensing gravitazionale forte.
«Lo studio di queste galassie, di come evolvono nel tempo le loro relazioni fondamentali, come quella tra quante stelle stanno formando e quante ve ne sono al loro interno, ci permette di investigare nel dettaglio come si sono formate e come si sono evolute le galassie nel corso della loro vita», precisa Andrea Enia dell’Università di Bologna, alla guida dell’articolo dedicato allo studio del tasso di formazione stellare delle galassie. «All’interno dello Euclid Deep Field South è possibile osservare l’ammasso di galassie J041110.98-481939.3, a poco più di sei miliardi di anni luce da noi. Questo insieme di galassie è talmente massivo da curvare la luce delle galassie che vi si trovano dietro proprio come una lente di ingrandimento, formando dei grandi archi secondo un fenomeno noto come lente gravitazionale. Le lenti gravitazionali sono uno strumento fondamentale per investigare in maggiore dettaglio la forma e la struttura di galassie molto lontane, usando l’universo come un telescopio naturale, con fattori di ingrandimento fino a cento volte».
Il Deep Field Fornax
Il terzo e più piccolo dei tre campi, lo Euclid Deep Field Fornax, occupa un’area nel cielo di soli 12,1 gradi quadrati – una cinquantina di lune piene – verso la costellazione della Fornace, anch’essa nell’emisfero sud. Comprende il Chandra Deep Field South, una porzione di cielo molto più piccola ma già studiata a fondo negli ultimi due decenni con un gran numero di telescopi terrestri e spaziali, su tutto lo spettro elettromagnetico. Dopo una singola osservazione, Euclid vi ha già individuato oltre 4,5 milioni di galassie.
Dalle prime analisi dei campi profondi di Euclid emerge la capacità del telescopio spaziale di rilevare oggetti deboli e distanti. In particolare, sono state individuate migliaia di potenziali galassie nane mai osservate prima, così come migliaia di misteriosi “puntini rossi” nell’universo remoto.
«Questo campo ha svelato una varietà di galassie con colori molto diversi, tra cui una popolazione di circa un migliaio di sorgenti eccezionalmente rosse: si ritiene che questi oggetti peculiari siano tra le galassie più massicce nell’universo distante, avvolte in un vasto serbatoio di polvere che le oscura pesantemente», ricorda Giorgia Girardi, dottoranda all’Università di Padova, prima autrice dell’articolo che indaga su queste enigmatiche sorgenti. «Grazie al grande impegno del consorzio Euclid, è stato possibile produrre cataloghi validati scientificamente delle sorgenti osservate all’interno del Fornax Deep Field e le osservazioni di Euclid si potranno combinare con le osservazioni di altri telescopi, come Spitzer nell’infrarosso e Lofar nelle onde radio. La possibilità di combinare informazioni a diverse lunghezze d’onda aiuterà a svelare la natura misteriosa delle sorgenti rosse e di molte altre famiglie extragalattiche».
Anche la morfologia e l’evoluzione delle galassie sono aspetti chiave per la legacy science di Euclid. La nuova release contiene infatti il primo catalogo dettagliato di oltre 380mila galassie, classificate in base a caratteristiche quali la presenza di bracci a spirale, barre centrali e code mareali che indicano possibili fenomeni di fusione galattica in corso. Il catalogo è stato creato dall’algoritmo di intelligenza artificiale Zoobot, supportato da un’intensa campagna di citizen science lanciata lo scorso agosto, a cui hanno partecipato quasi diecimila volontari nell’ambito del progetto Galaxy Zoo. Grazie al grande volume di dati, il catalogo ha già permesso di riconoscere differenze rispetto alle forme e alle caratteristiche delle galassie simulate.
«Euclid è una missione di tipo survey: un censimento. Il nostro obiettivo finale è quello di catalogare oltre un miliardo di oggetti celesti; tra questi decine di milioni di galassie», chiarisce Erik Romelli, ricercatore Inaf che ha guidato un altro degli articoli che accompagnano la Quick Data Release 1, dedicato alla realizzazione dei cataloghi in multi-frequenza. «All’interno delle stupende immagini ad alta risoluzione fornite dai due strumenti Vis e Nisp, il science ground segment, l’organo che si occupa di analizzare i dati della missione, ha il compito di identificare i singoli oggetti celesti, fornendo, per ognuno di loro, una stima accurata della sua posizione in cielo, della sua luminosità, della sua forma e delle sue proprietà fisiche. Per maneggiare la mastodontica mole di dati, l’Sgs sfrutta le capacità di 10 centri di calcolo sparsi tra Europa e Stati Uniti e la competenza e dedizione di centinaia di ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo».
Fonte: Media INAF

 Afrikaans
Afrikaans Shqip
Shqip አማርኛ
አማርኛ العربية
العربية Հայերեն
Հայերեն Azərbaycan dili
Azərbaycan dili Euskara
Euskara Беларуская мова
Беларуская мова বাংলা
বাংলা Bosanski
Bosanski Български
Български Català
Català Cebuano
Cebuano Chichewa
Chichewa 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 Corsu
Corsu Hrvatski
Hrvatski Čeština
Čeština Dansk
Dansk Nederlands
Nederlands English
English Esperanto
Esperanto Eesti
Eesti Filipino
Filipino Suomi
Suomi Français
Français Frysk
Frysk Galego
Galego ქართული
ქართული Deutsch
Deutsch Ελληνικά
Ελληνικά ગુજરાતી
ગુજરાતી Kreyol ayisyen
Kreyol ayisyen Harshen Hausa
Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi
Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית
עִבְרִית हिन्दी
हिन्दी Hmong
Hmong Magyar
Magyar Íslenska
Íslenska Igbo
Igbo Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Gaeilge
Gaeilge 日本語
日本語 Basa Jawa
Basa Jawa ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ Қазақ тілі
Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ
ភាសាខ្មែរ 한국어
한국어 كوردی
كوردی Кыргызча
Кыргызча ພາສາລາວ
ພາສາລາວ Latin
Latin Latviešu valoda
Latviešu valoda Lietuvių kalba
Lietuvių kalba Lëtzebuergesch
Lëtzebuergesch Македонски јазик
Македонски јазик Malagasy
Malagasy Bahasa Melayu
Bahasa Melayu മലയാളം
മലയാളം Maltese
Maltese Te Reo Māori
Te Reo Māori मराठी
मराठी Монгол
Монгол ဗမာစာ
ဗမာစာ नेपाली
नेपाली Norsk bokmål
Norsk bokmål پښتو
پښتو فارسی
فارسی Polski
Polski Português
Português ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬੀ Română
Română Русский
Русский Samoan
Samoan Gàidhlig
Gàidhlig Српски језик
Српски језик Sesotho
Sesotho Shona
Shona سنڌي
سنڌي සිංහල
සිංහල Slovenčina
Slovenčina Slovenščina
Slovenščina Afsoomaali
Afsoomaali Español
Español Basa Sunda
Basa Sunda Kiswahili
Kiswahili Svenska
Svenska Тоҷикӣ
Тоҷикӣ தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు ไทย
ไทย Türkçe
Türkçe Українська
Українська اردو
اردو O‘zbekcha
O‘zbekcha Tiếng Việt
Tiếng Việt Cymraeg
Cymraeg isiXhosa
isiXhosa יידיש
יידיש Yorùbá
Yorùbá Zulu
Zulu